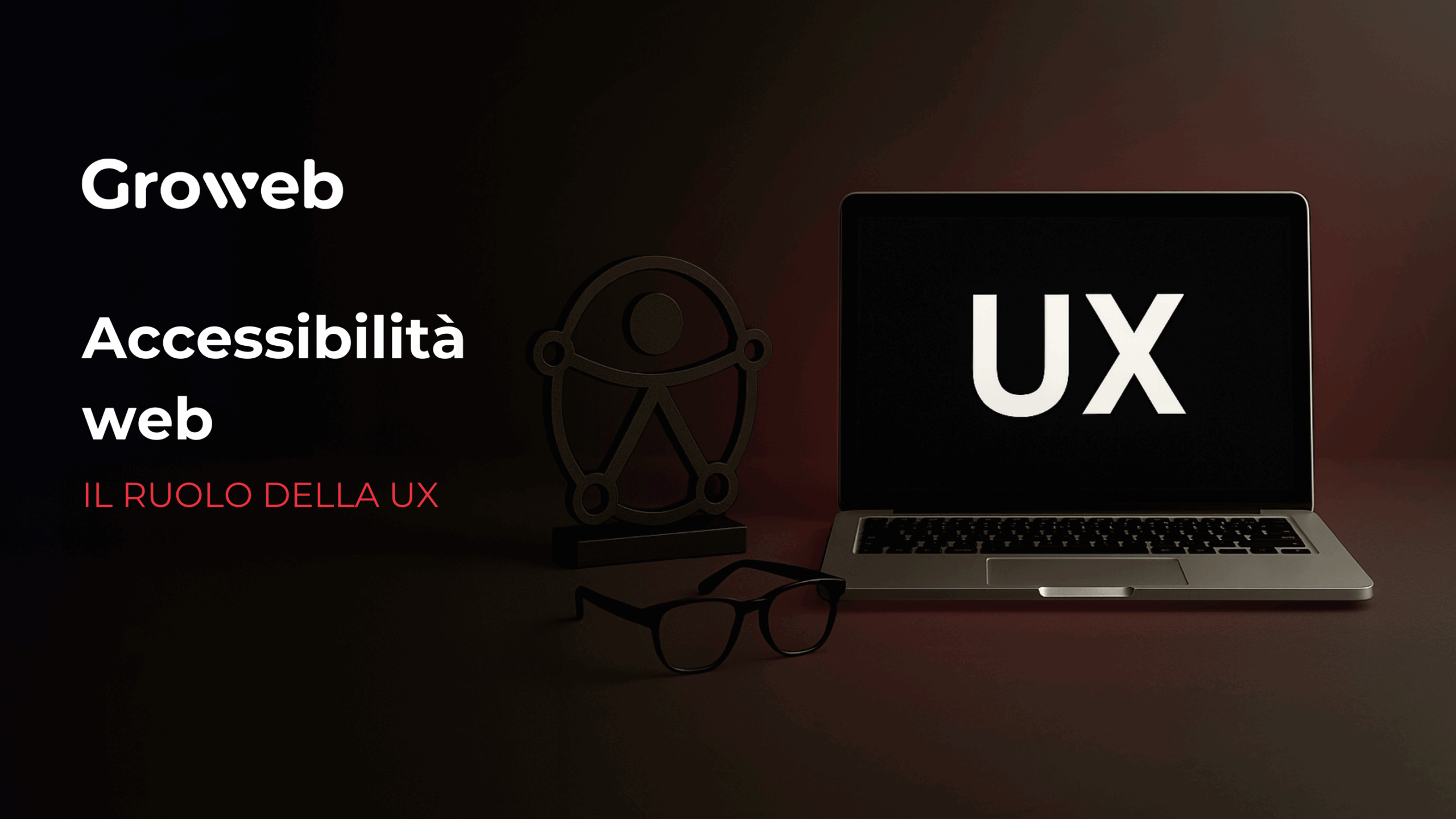L’accessibilità web si evolve sempre più: a partire dal 28 giugno 2025 sarà infatti obbligatorio, per la maggior parte delle aziende, aderire all’European Accessibility Act (ne abbiamo parlato nel dettaglio nell’articolo Accessibilità Digitale: cosa cambia da giugno 2025). E, al contrario di quanto si possa credere, seguire gli standard tecnici non basta per garantire uno spazio a portata di ognuno.
Un sito web è accessibile se la sua fruizione è agevole per tutti: perciò la UX assume un ruolo fondamentale. Approfondiamo la questione!
Accessibilità web e UX: due facce di una stessa medaglia
Sebbene accessibilità web e UX abbiano origini e obiettivi differenti, le loro strade si intersecano di continuo. Un’interfaccia intuitiva, coerente e ben strutturata, infatti, non soltanto assicura una buona esperienza generale, ma è in grado di rispondere alle esigenze più specifiche degli utenti.
Ad esempio, un modulo di contatto con etichette chiare, struttura logica e messaggi di errore altamente comprensibili sarà utile per utenti con disabilità visive parziali o che usano uno screen reader, perché:
- etichette definite associate ai campi di input consentono agli screen reader di leggere chiaramente il contesto di ogni campo;
- strutture logiche e coerenti aiutano questi utenti a navigare in modo comprensibile e lineare, senza la necessità di indovinare la funzione dei singoli elementi;
- messaggi di errore ben leggibili dai lettori di schermo permettono di correggere rapidamente gli sbagli senza frustrazioni.
UX designer e accessibility specialist, quindi, dovrebbero lavorare fianco a fianco sin dall’inizio dei singoli progetti per ottenere buoni risultati in termini di accessibilità web. Se ogni elemento dell’interfaccia è pensato dal principio per essere utilizzabile indipendentemente dalle abilità individuali, l’intero risultato sarà certamente più fruibile.
Favorire l’accessibilità web progettando esperienze inclusive
Progettare esperienze inclusive significa mettere al centro l’utente nella sua pluralità. Ciascuno di noi interagisce con il digitale in modo differente: alcuni usano screen reader, altri navigano solo da tastiera, altri ancora hanno disagio a barcamenarsi tra testi complessi e interfacce affollate a causa di una difficoltà cognitiva. Per garantire l’accessibilità web, la UX deve considerare queste variabili non come eccezioni, ma come priorità.
I principi del design inclusivo possono riassumersi in quattro pilastri fondamentali derivati dalle WCAG: percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto.
✅ Percepibile: le informazioni e i componenti devono essere presentati in modo che gli utenti possano percepirli con almeno uno dei loro sensi. Alcuni utenti non possono vedere o sentire determinati contenuti: bisogna perciò offrire un’alternativa che permetta loro di accedere all’informazione. Qualche esempio:
- contenuti visivi, come immagini e grafici, con alt text leggibili da screen reader;
- video con sottotitoli per persone sorde o con ipoacusia;
- testo e sfondo con un buon contrasto per le persone ipovedenti e/o daltoniche.
✅ Utilizzabile: l’interfaccia e i suoi componenti devono poter essere usati da chiunque, con qualsiasi modalità di interazione – non solo mouse o touchscreen. È importante perché molti individui navigano con tastiera, comandi vocali o dispositivi alternativi. Qualche esempio:
- possibilità di navigazione completa da tastiera (tab, invio, frecce) senza blocchi;
- pulsanti e link con area cliccabile sufficientemente grande;
- indicatori visibili del focus;
- assenza di contenuti eccessivamente lampeggianti (per evitare crisi epilettiche).
✅ Comprensibile: contenuti e funzionamento devono essere facili da comprendere, sia sul piano del linguaggio sia su quello delle interazioni. Un’interfaccia confusa e ambigua può infatti essere una barriera insormontabile per le persone neurodivergenti (spettro autistico, ADHD, dislessia e via dicendo). Qualche esempio:
- linguaggio semplice e diretto, privo di tecnicismi inutili;
- moduli con etichette chiare (“Inserisci i tuoi dati” invece di “Email”);
- messaggi di errore specifici (“Il campo nome non può essere vuoto”);
- strutture prevedibili (ad esempio, lo stesso layout in tutte le pagine servizio).
✅ Robusto: il contenuto deve essere interpretabile da un’ampia varietà di agenti utente, come browser e tecnologie assistive, sia oggi sia in futuro (in caso di aggiornamenti). Qualche esempio:
- uso corretto dell’HTML semantico (header, nav, main, footer);
- ARIA-label coerenti con la funzione del contenuto;
- esecuzione di test su diversi browser e screen reader;
- assenza di tecnologie obsolete o proprietarie che limitano la compatibilità.
Questi accorgimenti garantiscono l’accessibilità web non soltanto per le persone con disabilità in senso stretto, ma anche per chi, a causa di fattori culturali, età e background tecnologici particolari riscontra difficoltà nella navigazione.
Strumenti e best practice UX per l’accessibilità web
L’UX per l’accessibilità web non può prescindere dall’uso di strumenti e metodologie adeguate. Ad oggi, esistono moltissimi tool in grado di supportare il lavoro dei professionisti: WAVE, Axe e Lighthouse, ad esempio, analizzano le pagine e segnalano eventuali criticità in termini di contrasto, struttura semantica, alt text e navigabilità.
Tuttavia, gli strumenti automatizzati non sostituiscono il giudizio umano: è quindi necessario effettuare anche test con utenti reali. In particolare, osservare come le persone con disabilità navigano offre preziosissimi insight – che nessun software potrà mai restituire.
Le buone pratiche per l’accessibilità web includono, inoltre, l’adozione di specifici pattern: focus chiari, pulsanti ben visibili, form etichettati correttamente, elementi interattivi con target ampi. Il rispetto delle WCAG rappresenta una base solida, ma non esaustiva: l’obiettivo non è soltanto essere conformi, ma assicurare un’esperienza completa e dignitosa a tutti gli utenti che atterrano sulla piattaforma.
I vantaggi di un sito web accessibile
Investire nell’accessibilità web è una scelta non soltanto etica, ma anche strategica, che offre impatti positivi concreti. Come
- base utenti più ampia: se il sito è fruibile da tutti, le persone che possono accedere ai contenuti, acquistare i prodotti e usufruire dei servizi sono molte di più! Ciò comporta maggiore engagement e fidelizzazione;
- SEO migliore: vari accorgimenti legati all’accessibilità, come la presenza di alt text, titoli coerenti e strutture semantiche corrette sono apprezzati dai motori di ricerca. In più, un’interfaccia più chiara determina un abbassamento del tasso di abbandono e un aumento delle conversioni;
- brand reputation più solida: dimostrare attenzione all’inclusività rafforza l’immagine del marchio, soprattutto nei contesti pubblici e/o internazionali. Le aziende che investono nell’accessibilità vengono percepite come innovative, responsabili e attente ai bisogni reali delle persone;
- conformità legale: l’European Accessibility Act obbliga la maggior parte delle imprese a garantire l’accessibilità dei servizi digitali. Adeguarsi, quindi, è fondamentale per evitare sanzioni.
Cerchi un UX designer specializzato in accessibilità web?
Anche online, l’inclusività è ormai una necessità (per fortuna!). Perciò ogni componente di siti e piattaforme deve muoversi in questa direzione, incluso l’UX design.
Consapevoli di ciò, noi di Groweb ci impegniamo nella ricerca di soluzioni sempre migliori, più performanti e fruibili da tutti, prendendo attivamente parte al processo di cambiamento che punta a rendere il digitale uno spazio sicuro, protetto e privo di discriminazioni.
Se cerchi un partner affidabile, specializzato e competente per l’accessibilità web, contattaci: siamo pronti a partire! 🚀